Attaccamento e significato personale.
All’interno del processo dello sviluppo umano la ricerca di prossimità del bambino nei confronti dei genitori garantisce la sua sopravvivenza e permette l’attribuzione di significati alle tonalità emotive sperimentate nella relazione díattaccamento. In questo senso le possibili risposte delle figure genitoriali ai limitati schemi di riferimento del bambino, rendono possibile lo sviluppo di un numero relativamente circoscritto di esperienze esplicitate attraverso i principali pattern di attaccamento sviluppati da M. Ainsworth (A, B, C). All’interno dei rapporti di attaccamento il bambino ordina e modula le sue attivazioni emotive anche attraverso i significati che i genitori gli comunicano, secondo un processo che gli permette di esperire una sufficiente stabilità del proprio SÈ.
Pertanto, se si considera la conoscenza umana in una prospettiva ontologica, si può senz’altro affermare che, nel ciclo di vita individuale, riconoscersi è la prima spiegazione che riusciamo a darci del nostro sentirci vivereî (Guidano, 1992). In quest’ottica non si può conoscere senza esistere nel mondo, e il significato rappresenta il modo che ogni uomo ha di conoscere e valutare la sua esistenza: all’interno dell’intersoggettività gli altri convalidano la nostra identità e noi cerchiamo di percepirla come sufficientemente positiva da poter essere convalidata dagli altri che ci circondano. Secondo Guidano possiamo vedere il sistema conoscitivo di ciascuna persona come un’organizzazione di processi di significato che si autoregola.
L’organizzazione di significato personale, quindi, rappresenta il modo che ciascuno ha di organizzare la conoscenza, il modo con cui si rapporta alla sua esperienza immediata, come la decodifica e come poi la esplicita in una concezione del mondo articolata e complessa. La definizione guidaniana di significato personale rappresenta l’interfaccia tra l’esperienza immediata e líimmagine cosciente di sé; per meglio dire costituisce il modo con cui ciascuna persona si rapporta all’esperienza immediata decodificandola ed esplicitandola, attraverso la narrazione, in una concezione di sé e del mondo complessa.
L’esperienza, dunque, è il frutto dell’auto-organizzazione e si articola in due momenti fondamentali: il primo legato all’immediatezza del vivere, ad un senso di sé stessi e della vita non mediato dal pensiero che Guidano, riprendendo una classificazione di Mead (1972), definisce il SÈ; il secondo consiste nella narrazione/spiegazione dell’esperienza immediata al fine di riordinarla in un senso di SÈ coerente e stabile, definito il Me. La simultaneità di questi elementi permette all’uomo di vivere in modo esperienziale la propria soggettività. Il SÈ coincide con un livello di conoscenza tacita di se stessi, mentre il Me implica un livello esplicito della conoscenza di sé che si articola attraverso il linguaggio: questo permette all’uomo di sviluppare un senso personale come soggetto sia come oggetto (il Me) ed è proprio ciò che lo distingue dagli animali non-primati. Per fare un esempio l’esperienza che ciascuno di noi ha di sé stesso mentre guida un automobile è sia tacita (tutte le azioni da compiere nei modi e nelle sequenze esatte che abbiamo appreso con l’esperienza), sia esplicita (la descrizione di ciò che si sa di dover compiere, come se dovessimo raccontalo agli altri); quando si prova a rendere esplicita l’esperienza tacita ci si rende davvero conto di come questi due livelli di conoscenza sono simultanei eppure così diversi. Entrambi i livelli di conoscenza, tacita ed esplicita, sono interdipendenti e costituiscono un senso di SÈ coerente e stabile nel tempo, ciò che in poche parole si definisce identità personale. Questi due livelli interdipendenti concorrono alla formazione di una identità continua e stabile attraverso l’organizzazione della complessa realtà dentro e fuori l’essere umano.
Come la medicina si basa sul concetto che tutti i corpi umani sono riconducibili ad una strutturazione morfologica invariante, così Guidano cerca di individuare specifiche organizzazioni di significato seguendo l’invarianza dell’esperienza umana all’interno di una dimensione intersoggettiva. Non ritenendo che il set da lui individuato sia esaustivo di tutte le possibili organizzazioni, ne descrive quattro, ciascuna con differenti meccanismi di coerenza sistemica del significato personale: l’organizzazione di significato personale tipo Depressivaí; l’organizzazione di significato personale tipo Fobica; l’organizzazione di significato personale tipo DAP (disturbi alimentari psicogeni) e l’organizzazione di significato personale tipo Ossessiva.
Tutte queste organizzazioni regolano il loro significato personale, appunto, mediante l’esperienza della intersoggettività ed alle tonalità emotive che da questa esperienza emergono: tutti gli sforzi individuali tendono al mantenimento di una identità stabile e di un senso di autostima accettabile. Anche se sono identificate con termini psicopatologici in realtà esse sono svincolate dai sintomi, sono modi di conoscersi e conoscere peculiari, un processo in costante divenire finalizzato al mantenimento di un equilibrio che, quando assume caratteristiche di rigidità e stereotipia, o anche modalità troppo lasse nel mantenimento del senso di identità personale, evidenzia dei quadri psicopatologici. All’interno dell’organizzazione di significato depressivo, ad esempio, si possono stagliare diversi quadri patologici anche se con maggiore frequenza si presentano disturbi depressivi, nel significato fobico sono più frequenti disturbi díansia e così anche per le altre organizzazioni. Organizzazione di significato tipo depressiva (DEP)
Dal punto di vista evolutivo le caratteristiche relazionali allíinterno del sistema di attaccamento che favoriscono maggiormente la strutturazione di un significato depressivo nel bambino sono: la perdita di un genitore durante la fanciullezza, sia essa reale (morte, separazione dei genitori, ecc.) sia essa percepita (minacce di abbandono o di sottrazione di affetto genitoriale); líesperienza del bambino di non essere mai in grado di ottenere un attaccamento emotivo stabile e sicuro, nonostante i continui sforzi in questo senso (Bowlby, 1980) a causa di strategie parentali centrate sul ëcontrollo privo di affettoí (parental affectionless control) (Parker, 1983), e la precoce responsabilizzazione del bambino nella cura del genitore (inversione della relazione genitore-bambino) (Bowlby, 1980).
In tutti i casi citati sopra líesperienza intorno alla quale il bambino si percepisce come esistente Ë quella ëdi perditaí della reciprocit‡ affettiva, e gli schemi emozionali che si strutturano sono primariamente la disperazione per la perdita e la rabbia che ne attenua il carico di sofferenza altrimenti insopportabile. Líoscillazione anche molto rapida tra questi due stati emotivi si struttura con lo sviluppo, grazie anche ad una maggiore competenza cognitiva, attorno ad un equilibrio che garantisce uno stato di vicinanza agli altri sufficientemente accettabile, una sorta di distanza di sicurezza nelle relazioni: non troppo vicini per non soffrire dellíincapacit‡ di reciprocit‡ affettiva e non troppo lontani per non essere abbandonati.
Questo equilibrio diviene raggiungibile solo attribuendo al proprio SÈ un senso di non amabilit‡ che renda prevedibile líimprevedibile esperienza di perdita vissuta nellíinfanzia: lottare contro la propria negativit‡ percepita permette di controllare il ìsenso di passivit‡ e impotenza derivante dalla percezione della propria solitudineî (Guidano, 1988). Di fronte ad eventi di vita che possano essere vissuti come perdita di una o pi˘ relazioni significative (ad es. separazione o minaccia di separazione, malattia, morte, delusione che faccia rivedere líimmagine dellíaltro) o che portino il soggetto DEP a dover riconsiderare la
propria utilit‡ (ad es. licenziamento, crisi coniugale) le reazioni pi˘ comuni nelle persone con questa organizzazione sono di disperazione, con una implicazione maggiore rispetto alle reazioni depressive riscontrabili in qualsiasi altra organizzazione di significato poichÈ nei DEP i sentimenti di disperazione si generalizzano a tutti i settori dellíesistenza passata, presente e futura.
3. Organizzazione di significato tipo fobica (FOB)
Líequilibrio dinamico alla base dellíorganizzazione si muove allíinterno di due polarit‡ emotive contrapposte: il ëbisogno di protezioneí da un mondo percepito come pericoloso e il ëbisogno di libert‡í allíinterno dello stesso mondo. Il percorso evolutivo allíinterno del quale si struttura questa contrapposizione Ë caratterizzato da una relazione di attaccamento ansiosa che interferisce o limita pi˘ o meno indirettamente il naturale comportamento esploratorio del bambino.ßI comportamenti parentali possono essere anche molto diversi: parlare del mondo sempre in termini di pericolosit‡, enfatizzare le caratteristiche di fragilit‡ e vulnerabilit‡ del bambino, passare costantemente il messaggio al bambino che ad ogni suo allontanamento rischia di perdere le figure di accudimento per malattia, suicidio, o semplicemente perchÈ non gli si da la certezza che le possa ritrovare al suo ritorno, sono tutti messaggi passati in maniera pi˘ o meno implicita assumendo il significato che solo il controllo fisico costante puÚ rassicurare il bambino della presenza delle figure parentali. Uno sviluppo cognitivo ed emotivo armonico Ë il risultato di uno scambio dinamico tra percezione di una base sicura accessibile ai propri bisogni ma che lasci spazio ai progressivi comportamenti esploratori suscitati dalla curiosit‡ naturale verso il mondo.
Nellíorganizzazione di significato fobica questi due comportamenti divengono antitetici portando queste persone a dover selezionare il repertorio comportamentale che sia meno minacciante la propria integrit‡ del SÈ. In genere vi Ë una selezione di ëmodelli specifici di controllo decentralizzatoí, escludendo tutto il flusso sensoriale che attiva il bisogno di indipendenza e libert‡ e sviluppando attivit‡ neurovegetative distoniche (attacco di panico, somatizzazioni, ansia, ecc) finalizzate al mantenimento della vicinanza fisica delle figure protettive senza intaccare la propria autostima e senso di amabilit‡.
Le manifestazioni corporee associate ad una scarsa capacit‡ di elaborazione in termini cognitivi delle proprie esperienze portano queste persone a mantenere e regolare i legami affettivi attraverso la corporeit‡, sia essa controllo dellíaltro attraverso la vicinanza fisica sia attraverso un sintomo pi˘ o meno grave. Le esperienze percepite che possono suscitare una crisi in questa organizzazione di significato sono tendenzialmente riconducibili a perdita di protezione da parte di una o pi˘ figure significative che suscitano senso di solitudine (es. attacco di panico con senso di derealizzazione), o modificazione di un rapporto affettivo percepito in termini di perdita di libert‡ con relativo senso di costrizione (es. attacco di panico con senso di costrizione e soffocamento).
4. Organizzazione di significato tipo ëDisturbi Alimentari Psicogenií (DAP)
Sebbene questa organizzazione prenda il nome dallíacronimo di Disturbi Alimentari Psicogeni, come abbiamo detto anche per le altre organizzazioni, essa non Ë associabile ad uno specifico disturbo: la sua caratterizzazione deriva da una specifica modalit‡ di organizzare il significato personale propria anche di soggetti che mai presenteranno sintomi. I contributi maggiori allo studio di questa organizzazione provengono dalla Selvini Palazzoli (1963) e dalla Bruch (1973, 1978); líorganizzazione DAP Ë presente in entrambi i sessi sebbene sia stata studiata quasi esclusivamente in soggetti femminili a causa della sua visibilit‡ maggiore a livello sociale.ßLa caratteristica essenziale dellíorganizzazione di significato personale DAP Ë un senso di sÈ vago ed indefinito. Per far fronte a questo problema i soggetti DAP utilizzano due criteri: uno esterno ed uno interno. La ricerca di un riferimento (criterio) esterno, come ad esempio la ricerca di approvazione da parte di una persona significativa dal punto di vista affettivo, líuniformarsi ad uno standard considerato appropriato ed approvato socialmente, il sintonizzarsi sulle aspettative dellíaltro, il perfezionismo, sono finalizzati a prevenire possibili disconferme da parte degli altri; nel contempo temendo il giudizio altrui divengono loro stessi critici verso il mondo che li circonda, come a dire: ëti sminuisco io prima che tu possa farmi del maleí. Ogni disconferma esterna puÚ ripercuotersi sul senso di identit‡ personale aumentando il senso di inadeguatezza e vacuit‡ del SÈ.
Riferirsi sempre e comunque ad un criterio esterno per garantirsi una immagine di sÈ sufficientemente accettabile presenta pone queste persone di fronte a molte difficolt‡. Innanzitutto quella di non sentirsi sufficientemente adeguati nel soddisfare le aspettative altrui, oppure quella di sentirsi traditi, delusi od intrusi da delle aspettative esagerate. Nella ricerca di un punto di equilibrio interno che tuteli da questi pericoli, le persone con questa organizzazione spesso assumono comportamenti caratterizzati da chiusura e rifiuto ad esporre idee e convinzioni personali agli altri, anche ricorrendo frequentemente alla menzogna.
I soggetti DAP, anche quelli che nella loro vita non presenteranno uno scompenso clinico, generalmente si percepiscono come un ëbluffí, dato che cercano fortemente di dare uníimmagine positiva di sÈ allíesterno ma in realt‡,
avendo una sensazione molto vaga di sÈ, sentono di non essere in realt‡ come appaiono agli altri. Dal punto di vista del sistema di attaccamento sin dalle prime fasi di interazione della diade madre-bambino emerge una difficolt‡ di sincronizzazione reciproca tra le due figure. Le madri di soggetti DAP sono molto centrate sullíautocontrollo risultando poco disponibili a sintonizzarsi sui bisogni emotivi del figlio; ciÚ non significa che queste donne siano poco presenti nella vita dei loro figli, bensÏ che la loro presenza deriva pi˘ da un bisogno di sentirsi madri appropriate al giudizio esterno che da un piacere personale nellíaccudimento.
Il bambino allíinterno della diade regola il riconoscimento dei propri stati interni in relazione alle risposte materne mediate dallíaffettivit‡; ne segue che di fronte ad una presenza costante che perÚ viene percepita come inattenta e desincronizzata ai propri bisogni il bambino sviluppa un senso di sÈ vago ed indefinito, vivendo in modo indifferenziato anche i propri stati psicofisiologici. ìSi stabilisce un rapporto di reciprocit‡ in cui il bambino genera incertezza nei genitori e líincertezza dei genitori provoca turbolenza e confusione nel tentativo di organizzazione della conoscenza del bambino stessoî (Reda, 1986).ßIl bambino, in tali condizioni, sviluppa un senso profondo di inaffidabilit‡ nel riconoscere e decodificare i propri stati interni, in questa incertezza sentir‡ di poter provare e pensare solo ciÚ che Ë accettato allíinterno del rapporto di attaccamento vissuto come particolarmente coinvolgente. In questo stato di confusione sui propri segnali interni il bambino trova difficile demarcare il proprio sÈ dalle altre persone che gli sono vicino, provando un profondo senso di incompetenza ed inattendibilit‡ personale.
Un modo per far fronte a questo senso di vuoto e vaghezza del SÈ Ë ëguardareí alla figura di attaccamento, e con lo sviluppo agli ëaltrií significativi, focalizzandosi su punti di riferimento esterni che gli consentano di mantenere uní immagine del SÈ congruente e stabile nel tempo. ìIn un contesto relazionale in cui Ë preclusa ogni possibilit‡ di esprimere apertamente emozioni e opinioni autonome e definite, le strategie parentali di controllo consistono nel ridefinire costantemente le sensazioni e le emozioni del bambino (Ö), fino a quando egli non Ë in grado di avvertirle ed esprimerle in modo consono ai canoni familiariî (Guidano, 1988).
Tutta la famiglia Ë coinvolta nel mantenimento di un equilibrio interno basato sulla formalit‡ esteriore e sul controllo reciproco: questi tipi di famiglie sono state definite invischiate (Minuchin, Rosman e Baker, 1978). I modelli di attaccamento invischianti impediscono al bambino di organizzare e percepire autonomamente le proprie emozioni e sensazioni, lasciandogli durante líinfanzia una scarsa demarcazione tra il senso di sÈ e le rappresentazioni interne dei genitori. Questi genitori generalmente parlano dei loro figli, fino alla fase preadolescenziale, come dei bambini perfetti, una descrizione spesso in contrasto con i ricordi di soggetti DAP che ne caratterizzatano frustrazioni ed infelicit‡.
Tutto questo avviene fino a quando, in genere con la fase adolescenziale, i ragazzi DAP relativizzano líimmagine dei genitori percepita fino ad allora assoluta e perfetta, elemento esterno a cui riferirsi per mantenere un livello accettabile di autostima, provando un profondo senso di delusione. Con líadolescenza líIo si struttura seguendo un andamento oscillante tra il bisogno di riferirsi allíesterno per riconoscere i propri stati interni, percependosi come incompetente nel mettere a fuoco la propria individualit‡, ed il sentire la parte pi˘ definita e stabile di SÈ corrispondente ad un senso di inattendibilit‡ personale. ßSi alternano un senso di vuoto ed una esperienza di SÈ poco definita che spingono i soggetti DAP a prendere come punto di riferimento líesterno, ed in particolare le aspettative degli altri, in primis quelle genitoriali, strutturando un senso di SÈ sufficientemente costante nella misura in cui riesce ad aderire a queste aspettative. In questíottica si intuisce come gli episodi nei quali, il bambino prima e líadulto poi, si sente rifiutato (disconferme, abbandoni) generano in lui una profonda delusione aumentando la vaghezza del senso di SÈ e gettandolo in una estrema confusione; per limitare questi vissuti il DAP tende ad evitare il pi˘ possibile le situazioni nelle quali deve esporsi al giudizio esterno, allontanando cosÏ anche la possibilit‡ di un giudizio negativo o un rifiuto: esperienza per lui troppo dolorosa.
5. Organizzazione di significato tipo ossessiva (OSS)
Líaspetto centrale di questa organizzazione Ë líelaborazione di un senso di SÈ ambivalente e dicotomico. Gli aspetti invarianti nei comportamenti parentali sono costituiti da modelli di attaccamento ambivalente: una figura genitoriale generalmente meno rilevante che affianca líaltra caratterizzata da sentimenti ambivalenti e antitetici nei confronti del bambino. Il comportamento pi˘ frequente Ë quello in cui un genitore si dedica completamente allíeducazione morale e sociale del bambino con abnegazione ammirabile senza mai esprimere tenerezza o altre manifestazioni emotive, anzi spesso celando addirittura ostilit‡ e rifiuto. ìLa simultaneit‡ di questi due aspetti contraddittori del comportamento parentale sembra essere un prerequisito essenziale per un itinerario di sviluppo ossessivoî (Guidano, 1988).
Il vissuto del bambino di fronte a tale ambivalenza Ë caratterizzato da senso di incontrollabilit‡ e imprevedibilit‡ riguardo le possibili conferme o disconferme che possono arrivare dalle figure parentali, il risultato Ë che il bambino non puÚ non scegliere di decodificare il messaggio in un senso positivo (conferma al SÈ) o negativo (disconferma del SÈ), ma in entrambi i casi la scelta risulta sempre logicamente sbagliata: questa Ë la situazione che caratterizza il ëdoppio legameí (Bateson, Jackson e altri, 1956).
Crescere in un ambiente familiare che seleziona il piano comunicativo logicoanalitico a scapito di quello motorio ed espressivo determina che la migliore dimostrazione di affetto che il bambino possa dare ai genitori ìviene proprio a coincidere con ciÚ che sembrerebbe essere il suo opposto, e cioË un comportamento serio, riflessivo e distaccatoî (Guidano, 1988); lo sviluppo dellíidentit‡ del bambino in questo contesto segue lo stesso piano antitetico nel quale ci si sente amabili e non amabili allo stesso tempo e si Ë costretti a scegliere ogni volta tra le due possibilit‡ per raggiungere un senso di SÈ attendibile, escludendo e controllando il continuo affiorare di sensazioni contraddittorie e inconciliabili.ßLe immagini e le emozioni sono processi che tacitamente comprendono informazioni confuse e anche contrastanti tra loro, dunque le persone con questa
organizzazione usano quasi esclusivamente i processi verbali (a scapito di quelli analogici) nei quali sono molto competenti, per conquistare quella ëcertezzaí che dia loro un senso di SÈ sufficientemente unitario e stabile. ìNel caso che sensazioni discrepanti affiorino comunque, un intero repertorio di attivit‡ diversive potr‡ distogliere líattenzione selettiva da una loro ulteriore elaborazione. Queste attivit‡ prendono essenzialmente la forma di pensieri ripetitivi (ruminazioni, dubbi, ecc.) che appaiono pressochÈ invariabilmente connessi con azioni stereotipe (rituali).î (Guidano, 1988).
Nel bisogno costante di scegliere per avere la certezza di comportarsi nel modo ëpi˘ giustoí i soggetti OSS aderiscono in modo inflessibile a norme e regole morali che li portano ad assumere quel caratteristico atteggiamento perfezionistico e pedante. Questa ricerca del giusto comportamento riguarda anche il dominio emotivo; queste persone infatti percepiscono le perturbazioni emotive come destabilizzanti e usano il controllo cognitivo minuzioso e continuo delle attivazioni psicofisiologiche per ordinarle, codificarle e dunque controllarle.
Di fronte, perÚ, a situazioni emotivamente significative in cui Ë difficile discriminare con certezza gli aspetti ëpositivií da quelli ënegativií (es. crisi coniugale, difficolt‡ nella vita sessuale, gravidanza e parto, perdita di una persona cara, fallimenti lavorativi) diviene per i soggetti OSS estremamente difficile capire la situazione e dunque prendere la relativa decisione. Questi eventi di vita possono essere estremamente destrutturati in questa particolare organizzazione di significato, suscitando sensazioni ambivalenti e perturbanti con emergenza di immagini intrusive che rendono nullo ogni tentativo di mantenere stabile líimmagine di SÈ, tanto che la persona OSS, secondo la sua tipica procedura di pensiero ëtutto o nullaí, ricorrer‡ a pensieri e schemi comportamentali ripetitivi e ritualizzati per riappropriarsi di un senso di controllo sulla sensazione di negativit‡ da cui si sente invaso.ß6. Conclusioni
La dimensione sistemico-processuale dello sviluppo umano approfondita dal pensiero di Vittorio Guidano, non considera pi˘ la personalit‡, come anche la psicopatologia, in termini descrittivi, ma la inquadra allíinterno di un processo in costante divenire, finalizzato al mantenimento di un equilibrio. Questo Ë uno dei concetti fondamentali dellíapproccio postrazionalista: il processo di auto-organizzazione Ë un meccanismo basilare per ogni essere umano che non puÚ prescindere dal modo di osservare e percepire dellíindividuo stesso.
Líauto-organizzazione includendo elementi esterni ed interni allíessere umano fornisce allíindividuo una esperienza, un senso di coerenza e continuit‡ nel tempo. Le organizzazioni di significato personale ci mostrano come lo sviluppo ontogenetico segua un percorso senza fine non lineare ma a spirale, giocato tra la percezione immediata del mondo e le emozioni esperite e la loro spiegazione, integrando questi aspetti in termini di unitariet‡ e continuit‡ del proprio SÈ.
Bibliografia
Bateson G., Jackson D.D., Haley J. E Weakland J. (1956), Verso una teoria della schizofrenia, trad. it. In Cancrini (1977).
Bowlby J. (1980), Attachment and Loss: III, Loss: Sadness and Depression. Hogarth Press, London. (Trad. It. Attaccamento e perdita: 3, La perdita della madre, Boringhieri, Torino, 1983).
Bruch H. (1973), Eating disorders, Basic Book, New York (trad. It. Patologia del comportamento alimentare, Feltrinelli, Milano, 1977).
Bruch H. (1978), The golden cage, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) (trad. It. La gabbia d’oro, Feltrinelli, Milano, 1981).
Guidano V.F. (1987), Complexity of the Self. Guilford, New York, (Ed. it.: La complessit‡ del SÈ. Bollati Boringhieri, Torino, 1988).
Guidano V.F. (1991), The Self in Progress. Guilford, New York, (Ed. it.: Il SÈ nel suo divenire. Bollati Boringhieri, Torino, 1992).
Mead G.H., Mente, SÈ e societ‡, trad. it. (il Mulino, Bologna 1972). Ed. Or.: 1934. Minuchin S., Rosman B.L., Baker L. (1978), Psychosomatic families: anorexia nervosa in context, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
Parker G. (1983), Parental ìAffectionless Controlî a san Antecedent to Adult Depression, Archs gen. Psychiat., vol. 40, 956-60.
Reda M.A. (1986), Sistemi cognitivi complessi e psicoterapia, Nis Edizioni, Roma.
Seligman M.E.P., Abramson L.Y., Semel A. e Baeyer S. (1979), Depressive Attributional Style, J. Abnorm. Psychol., vol. 8.
Selvini Palazzoli M. (1963), Líanoressia mentale, Feltrinelli, Milano.
Sludzki C.E., Veron E. (1976), The Double-Bind as a Universal Pathogenic Situation, in Sludzki e Ransom.
Questo paragrafo approfondisce l’argomento introdotto in precedenza, sviluppando l’idea principale con esempi, analisi o contesto aggiuntivo. Usa questa sezione per elaborare punti specifici e assicurati che ogni frase si basi sulla precedente per mantenere un flusso coerente. Puoi includere dati, aneddoti o opinioni di esperti per rafforzare le tue affermazioni. Mantieni il linguaggio conciso ma abbastanza descrittivo da mantenere i lettori coinvolti. Qui inizia a prendere forma la sostanza del tuo articolo.
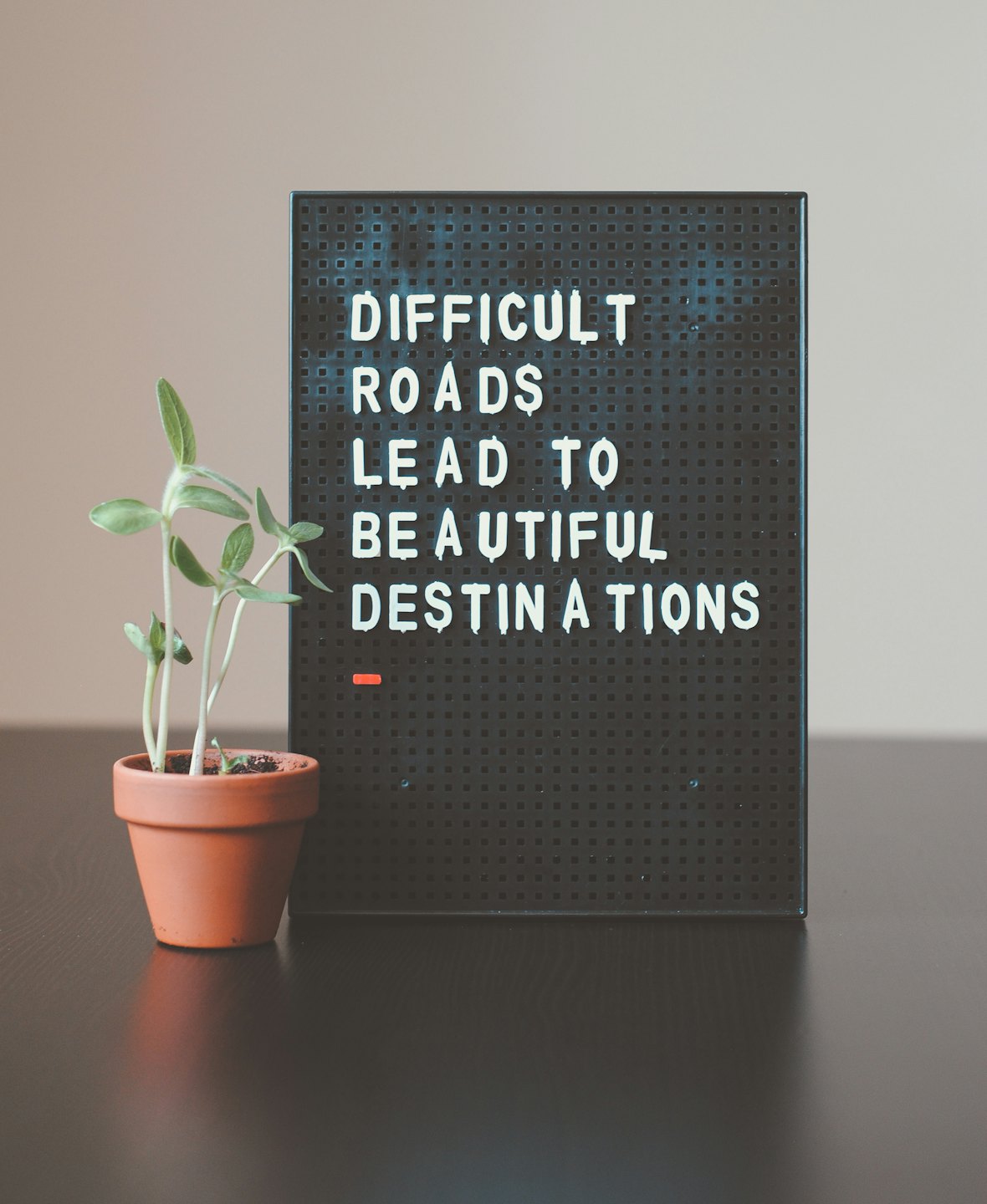
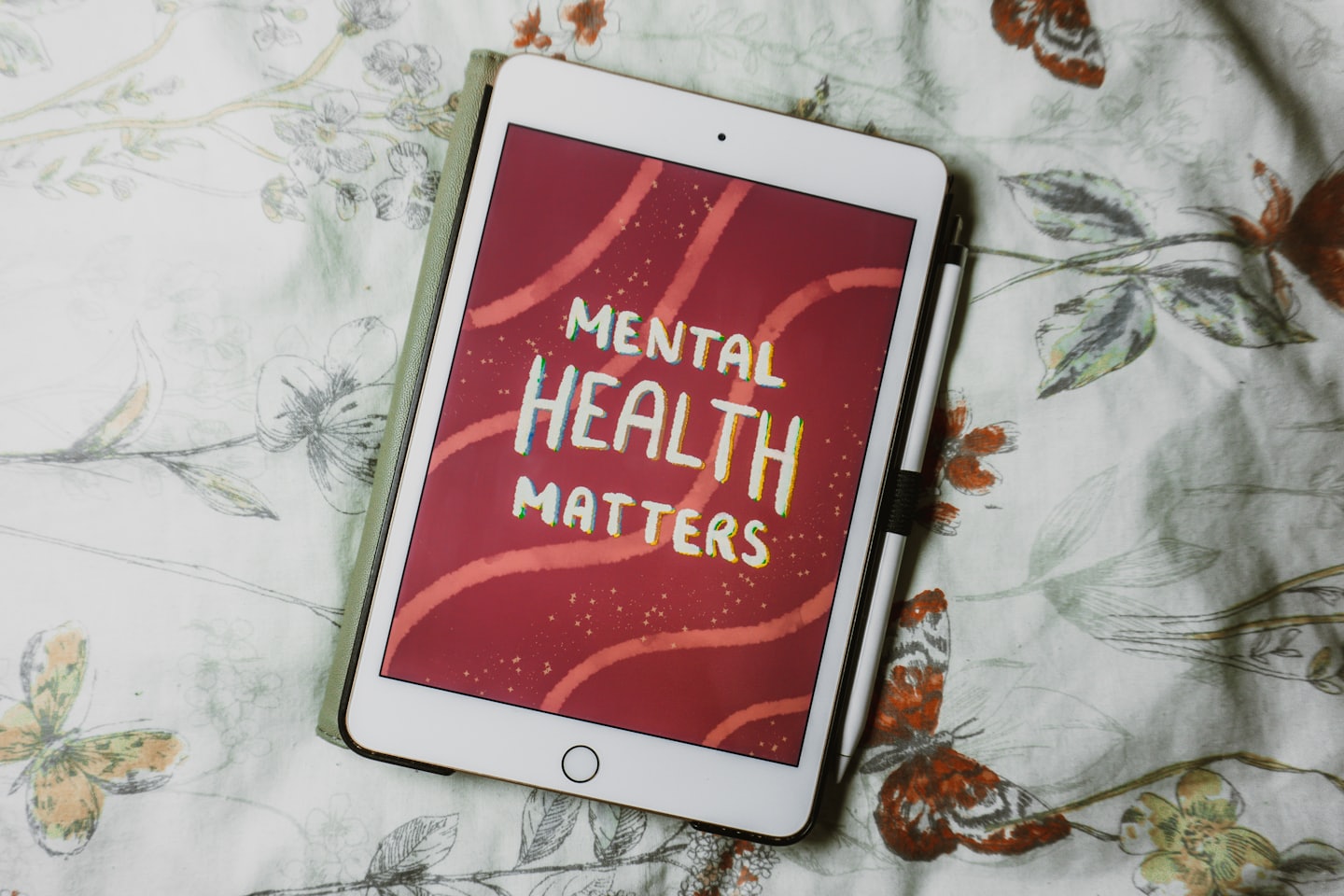
Avvicinandoti al centro dell’articolo, questo paragrafo offre l’opportunità di collegare idee precedenti con nuove intuizioni. Usa questo spazio per presentare prospettive alternative o rispondere a possibili domande che i lettori potrebbero avere. Trova un equilibrio tra profondità e leggibilità, assicurandoti che le informazioni rimangano facilmente comprensibili. Questa sezione può anche servire come transizione verso i punti conclusivi, mantenendo il momentum mentre guidi la discussione verso le sue fasi finali.
Conclusione con approfondimenti chiave
In questo paragrafo conclusivo, riassumi i punti chiave trattati nell’articolo, rafforzando le idee più importanti. Incoraggia i lettori a riflettere sugli approfondimenti condivisi o offri consigli pratici che possano applicare nella loro vita. Questa è la tua occasione per lasciare un’impressione duratura, quindi assicurati che i tuoi pensieri finali siano incisivi e memorabili. Una conclusione forte non solo lega l’articolo insieme, ma ispira anche i lettori a coinvolgersi ulteriormente.

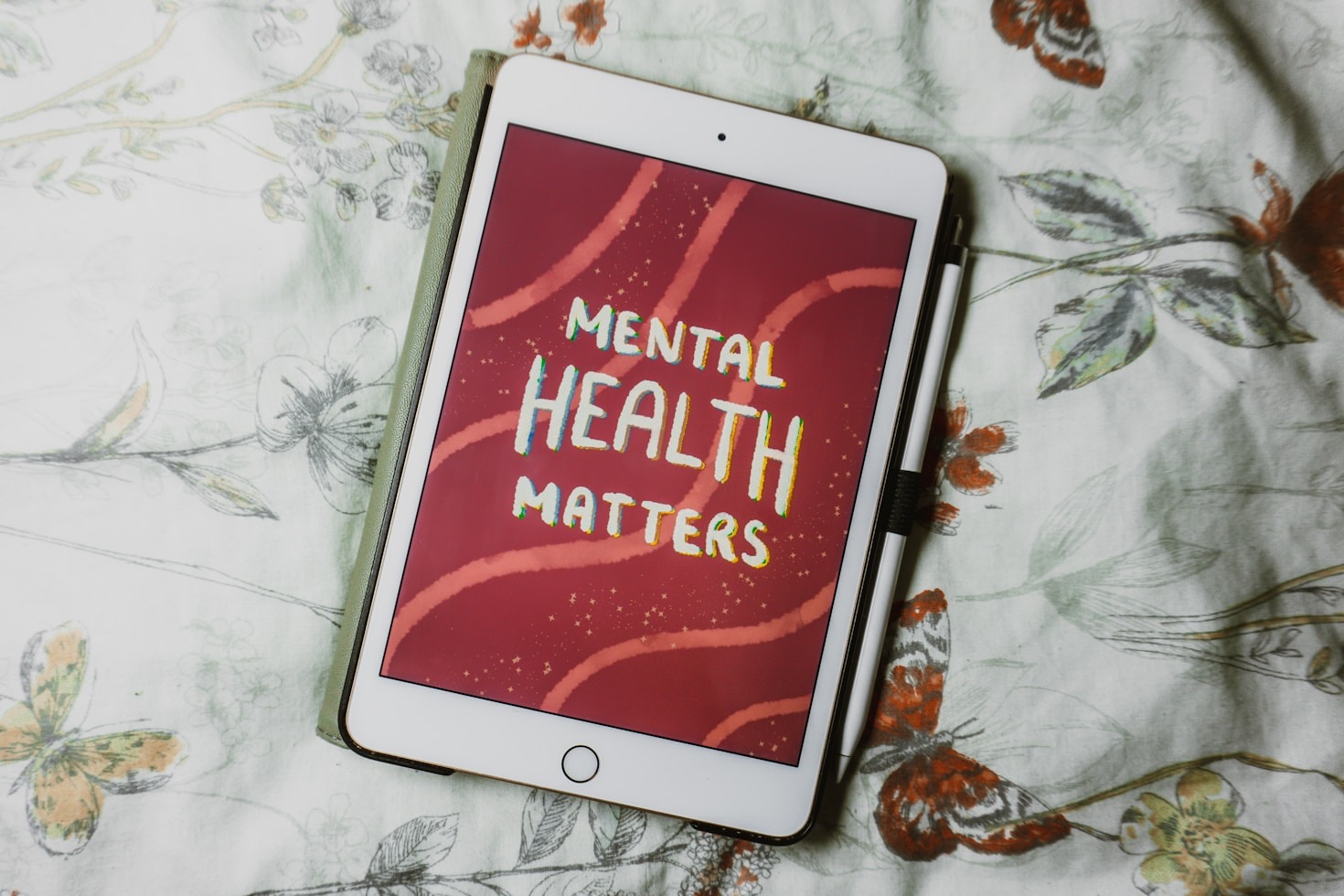
Lascia un commento